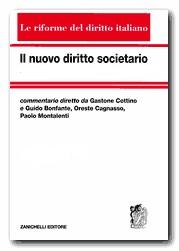Il Nuovo Diritto Societario nella Dottrina e nella Giurisprudenza: 2003-2009
- Editore
- Zanichelli
- Autori
- Gastone Cottino - Guido Bonfante - Oreste Cagnasso - Paolo Montalenti
- Categoria
- Diritto
- Collana
- Le riforme del diritto italiano
- Pagine
- 1508
- Pubblicato
- Ottobre 2009
- Codice ISBN
- 9788808151469
- Prezzo di listino
- €
200,00 - a Voi riservato
- € 190,00
- Promozione
-

Descrizione
L’opera offre dunque un quadro aggiornato e rivisitato – alla luce del lavoro degli interpreti, delle elaborazioni della prassi e delle integrazioni legislative – della vigente disciplina, civile e penale, delle società di capitali e delle cooperative.
Getta un ponte tra la riforma e le sue prime applicazioni: e pur privilegiando, com’è naturale, la segnalazione e la messa a fuoco delle novità, spesso radicali, che essa ha introdotto, dello spirito e della ratio che le sottendono, delle loro implicazioni sia teoriche che pratiche, le riconduce alle regole, principi e problemi generali, alle loro radici nel diritto preesistente. Sia pure nell’ambito di un disegno complessivo che tocca tutti gli aspetti della riforma societaria del 2003, particolare attenzione è dedicata sia alle più recenti novità normative, anche di derivazione comunitaria (opa, interventi anti-crisi per il settore bancario, recepimento delle modifiche alla II Direttiva, progetto di legge sulla c.d. record date; società pubbliche) sia ai temi sui quali più ampio è il dibattito dottrinale e giurisprudenziale (struttura finanziaria della società per azioni; ruolo dell’assemblea nella gestione sociale; sistemi alternativi di amministrazione e controllo; responsabilità del socio nella s.r.l.; gruppi di società). Cucendo gli innesti con il sistema globale mira pertanto ad offrire agli addetti ai lavori, siano essi studiosi o professionisti, strumenti utili ad orientarsi nel talora intricato reticolo delle innovazioni senza tuttavia sacrificare, in una visione d’insieme, la percezione costante delle linee guida e travi portanti del sistema.
INDICE SOMMARIO
XVII PRESENTAZIONE
GASTONE COTTINO
PARTE I
SOCIETÀ PER AZIONI: COSTITUZIONE, PATTI PARASOCIALI E STRUTTURA
FINANZIARIA
3 Capitolo I
Introduzione alla struttura finanziaria della s.p.a.: capitale sociale, azioni e strumenti
finanziari tra riforma del diritto societario e recenti interventi legislativi
NICCOLÒ ABRIANI
1. La società per azioni come disciplina dell’investimento: gli obiettivi della riforma e i primiriscontri applicativi, p. 3 – 2. (Segue): investimento azionario, strumenti partecipativi etitoli obbligazionari,
p. 8 – 3. La c.d. «semplificazione» della disciplina dei conferimentiin natura, dell’acquisto di azioni proprie e del divieto di assistenza finanziaria di cui al
d.lgs. 142/2008: un inquadramento preliminare, p. 11 – 4. I regimi alternativi previstidall’art. 2343 ter c.c. A) Il conferimento senza stima di «valori mobiliari» e «strumenti delmercato monetario»,
p. 15 – 5. (Segue): B) Il conferimento sulla base del «valore equo» risultanteda bilancio, p. 18 – 6. (Segue): C) Il conferimento sulla base del «valore equo» risultanteda una valutazione precedente di non oltre sei mesi operata da un esperto indipendente
dotato di adeguata e comprovata professionalità, p. 21 – 7. (Segue): concorrenza disegualetra regimi eterogenei.
Appeal e limiti della nuova disciplina, p. 23 – 8. Responsabilità degliamministratori e ambito del controllo notarile, p. 25 – 9. L’acquisto illimitato di azioni proprienelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: inedite prospettive
applicative e nuovi dubbi interpretativi, p. 29 – 10. Il superamento «condizionato » del divietodi assistenza finanziaria: il ruolo degli amministratori,
p. 35 – 11. (Segue): ancora sullealtre operazioni sulle proprie azioni (con un cenno al merger leveraged buy out), p. 38 –
12. La parabola del capitale sociale e lo zelo semplificatorio del legislatore italiano: per unsupplemento di riflessione, p. 41 – 13. Categorie azionarie e strumenti finanziari partecipativinella recente disciplina anti crisi: prime considerazioni sui «Tremonti
bond» (d.l. 185/2008,l. 2/2009 e d.m. 25 febbraio 2009), p. 45 – 14. (Segue): sulle azioni di partecipazione allebanche che versino in una «situazione di inadeguatezza patrimoniale » (d.l. 155/2008 e
l. 190/2008), p. 57
61 Capitolo II
Atto costitutivo e condizioni per la costituzione
PAOLO FIORIO
1. L’atto costitutivo, p. 61 – 2. Le condizioni per la costituzione, p. 63
67 Capitolo III
I patti parasociali
PAOLO FIORIO
1. Premessa, p. 67 – 2. Efficacia ed esecuzione in forma specifica dei sindacati di voto, p. 68 –
3. I sindacati di gestione, p. 73 – 4. I patti che limitano il trasferimento delle azioni, p. 74 –
5. Validità ed efficacia dei patti parasociali che interferiscano con il diritto di recesso, p. 76 –
6. La durata dei patti, p. 79 – 7. La pubblicità dei patti parasociali, p. 81 – 8. Patti parasocialie mercato del controllo: le novità introdotte dal d.lgs. 229/2007 e le modifiche apportate
dalla l. 2/2009, p. 84 – 9. La «neutralizzazione» dei patti parasociali nel corso di un’offerta
ex artt. 106 e 107 t.u.f.: il diritto di recesso, p. 87 – 10. La «neutralizzazione» dei patti parasocialiprevista dallo statuto ai sensi dell’art. 104 bis, p. 93
97 Capitolo IV
I conferimenti
ANGELO BERTOLOTTI
1. Premessa, p. 97 – 2. Il dibattito dottrinale, prima e dopo la riforma, sul capitale sociale esulla sua funzione, p. 98 – 3. Conseguenze sul piano normativo: la direttiva 2006/68/CE e
l’introduzione degli artt. 2343 ter e 2343 quater c.c., p. 102 – 3.1. L’art. 2343 ter, p. 104 –
3.2. L’art. 2343 quater, p. 110 – 3.3. Un interrogativo, p. 113 – 4. La compensabilità tra debitoconseguente alla sottoscrizione di un conferimento in denaro e credito del sottoscrittore
nei confronti della società: le posizioni della giurisprudenza con richiami a quelle della
dottrina, p. 115 – 5. Status di socio in presenza di conferimenti «asimmetrici»: le tesi dottrinali,
p. 121
125 Capitolo V
Le azioni
ANNAMARIA DENTAMARO
1. I confini della fattispecie azionaria: la connotazione oggettiva e la soggettivizzazione consentita;atipicità di contenuto e tipicità rappresentative e circolatorie, p. 125 – 2. Rappresentazionedella partecipazione sociale, tecniche di legittimazione e leggi di circolazione delle
azioni, p. 130 – 3. Azioni e valore nominale, p. 135 – 4. Circolazione delle azioni, p. 138 –
5. Limiti alla circolazione delle azioni. Ambito applicativo, p. 146 – 6. Clausole che vietanoil trasferimento, p. 149 – 7. Clausole di prelazione. Clausole c.d. co-vendita (tag along, dragalong
e bring along), p. 152 – 8. Clausole di gradimento, p. 161 – 9. Violazione dei limiti allacircolazione delle azioni, p. 166 – 10. Trasferimenti mortis causa, p. 170 – 11. Categoriedi azioni,
p. 172 – 12. Categorie di azioni e i confini imposti dalla legge, p. 178 – 13. (Segue):categorie di azioni e diritto di voto, p. 183 – 14. Categorie di azioni e diritti patrimoniali,
p. 189 – 15. Quotazione e categorie speciali di azioni, p. 192 – 16. Categorie di azionie disciplina dell’opa, p. 197 – 17. La speciale disciplina applicabile ai titoli azionari. L’art.2437, 2° co., lett. b), c.c.,
p. 200 – 18. (Segue): il contenuto del titolo azionario. Gli artt.2354 c.c. e 2355 bis, ult. co., c.c., p. 201 – 19. Introduzione alla nuova disciplina dell’acquistodi azioni proprie e alla normativa in tema di assistenza finanziaria,
p. 209 – 20. La disciplinadell’acquisto di azioni proprie, p. 210 – 21. La riserva azioni proprie, p. 215 – 22. Il divieto
di assistenza finanziaria, p. 219 – 23. Le partecipazioni reciproche. Cenni, p. 226
227 Capitolo VI
Le azioni correlate
GIANNI MIGNONE
1. Le azioni correlate: realtà applicativa; le azioni correlate ai risultati di una controllata; ilconcetto di «settore», p. 227 – 2. (Segue): le azioni correlate non sono azioni privilegiate insenso tecnico. I criteri di correlazione,
p. 231 – 3. (Segue): azioni di risparmio correlate;azioni correlate ad un affare oggetto di patrimonio destinato; necessità di una delibera di di-
stribuzione degli utili? Diritti in sede di liquidazione, p. 236 – 4. (Segue): rendicontazione;diritti di voto (e di nomina); diritto di opzione; assemblea speciale; conversione e riscatto
delle azioni correlate; conflitti d’interesse, p. 239
249 Capitolo VII
Le obbligazioni
ANNAMARIA DENTAMARO
1. Le obbligazioni a sei anni dalla riforma. Il concetto di obbligazione e l’ambito applicativodella disciplina, p. 249 – 2. I limiti all’emissione del prestito obbligazionario: la ratio, p. 254 –
3. (Segue): i singoli limiti, p. 256 – 4. Le «obbligazioni speciali» ex art. 12, l. 2/2009: cennoe rinvio, p. 273 – 5. Le obbligazioni «convertibili» e quelle «cum warrant»: questioni aperte,
p. 274 – 6. Prestito obbligazionario e vicende societarie, p. 277 – 7. La circolazione dei«prodotti finanziari» ex art. 1, 1° co., lett. u), t.u.f., p. 282 – 8. L’organizzazione degli obbligazionisti,
p. 285 – 9. Creazione del prestito: competenza e procedimento, p. 290 –
10. (Segue): i vizi del procedimento di emissione. Cenni, p. 295
299 Capitolo VIII
Gli strumenti finanziari di cui al 6° co. dell’art. 2346
299 SEZIONE I
DISCORSO GENERALE. DIRITTI PATRIMONIALI
GIANNI MIGNONE
1. Premessa, p. 299 – 2. Possibili usi degli strumenti finanziari ex art. 2346, 6° co., p. 301 –
3. Rapporto fra gli strumenti finanziari ex art. 2346, 6° co., e quelli ex art. 1 t.u.f., p. 302 –
4. Circolabilità, negoziabilità, incorporabilità, serialità, documentalità, p. 304 – 5. Rapportofra gli strumenti di cui al 6° co. dell’art. 2346 e gli «strumenti finanziari, comunque denominati,
che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico
della società», di cui all’art. 2411, 3° co., c.c., p. 307 – 6. Sul significato del termine «partecipativi», p. 313 – 7. Sulla natura di titoli di debito degli strumenti finanziari ex art. 2346, 6°
co. (l’appostazione in bilancio degli strumenti), p. 318 – 8. Quando il «rischio» è «debito»,
p. 322 – 9. L’emissione degli strumenti: l’organo competente; possibilità che essa non siaprevista originariamente dallo statuto; limiti quantitativi, p. 325 – 10. Strumenti finanziariconvertibili in altri strumenti, o in azioni
. Diritti di opzione su strumenti finanziari, o dei titolaridi strumenti su azioni, p. 329 – 11. Strutturazione dei diritti patrimoniali. Sulle cosiddette
«reverse convertible», p. 331 – 12. In particolare, sull’apporto in natura, p. 331
333 SEZIONE IIDIRITTI AMMINISTRATIVI
GIANNI MIGNONE
1. Rapporto fra diritti patrimoniali e diritti amministrativi: si possono attribuire i secondi indipendentementedai primi?, p. 333 – 2. Sul problema se i diritti amministrativi riconoscibiliagli strumenti siano soltanto quelli della gamma che fa capo agli azionisti di s.p.a., o possano
anche essere diritti ulteriori e diversi, p. 335 – 3. (Segue): diritti che, restando nella sferadi quelli «spettanti ai soci» (singoli o minoranza), possono essere attribuiti al portatore di
strumenti, p. 337 – 4. (Segue): diritti amministrativi ulteriori rispetto a quelli dei soci, ritenutiattribuibili al portatore di strumenti,
p. 338 – 5. Portata degli «argomenti specificamenteindicati», di cui al 5° co. dell’art. 2351 c.c., sui quali si esercita il diritto di voto dei portatori
di strumenti, p. 339 – 6. Il luogo in cui i portatori di strumenti esercitano il diritto di voto «suargomenti specificamente indicati». In particolare, se debba trattarsi necessariamente di
un’assemblea, p. 341 – 7. Portata della figura del «componente indipendente del consiglio diamministrazione o del consiglio di sorveglianza o (…) sindaco», eleggibile dai portatori di
strumenti, p. 343 – 8. Il luogo in cui i portatori di strumenti esercitano il diritto di nominareun componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza
o un sindaco. Se trattasi di nomina diretta o di mera designazione, p. 346 – 9. Numero diamministratori e sindaci che possono essere nominati dai portatori in caso di più emissioni
di strumenti, p. 347 – 10. La legittimazione alla revoca degli amministratori nominati ex art.2351, ult. co., p. 347 – 11. Se siano individuabili limiti quantitativi ai voti globalmente esercitabilidagli strumenti finanziari e se vi debba essere una proporzione fra entità dell’apporto
e «peso» del voto attribuito ai relativi strumenti, p. 348 – 12. Strumenti finanziari emessi
dalle banche e sottoscritti dallo Stato, p. 348
PARTE II
SOCIETÀ PER AZIONI: ORGANI
353 Capitolo IX
Introduzione alla disciplina degli organi sociali
PAOLO MONTALENTI
1. Premessa, p. 353 – 2. Il rapporto assemblea-amministratori. Le autorizzazioni, p. 353 –
3. Il ruolo dell’assemblea, p. 354 – 4. L’assemblea nelle società quotate, p. 355 – 5. L’invaliditàdelle deliberazioni: dalla tutela reale alla tutela risarcitoria, p. 356 – 6. L’amministrazionesociale: le principali novità. Assetti organizzativi, diligenza professionale, organi delegati,
conflitto di interessi, azione di responsabilità, informazione contabile, p. 357 – 7. I modelli
alternativi di governance. Il sistema monistico, p. 359 – 8. Il sistema dualistico, p. 361 –
9. Le operazioni con parti correlate. La proposta di regolamento Consob, p. 363 – 10. Il collegiosindacale, p. 365 – 11. Il controllo contabile, p. 366 – 12. I controlli societari: una materia
ancora da riformare, p. 366
369 Capitolo X
L’assemblea: competenze e procedimento
369 SEZIONE ILE COMPETENZE
BARBARA PETRAZZINI
1. Un tentativo di ricognizione delle competenze dell’assemblea ordinaria non elencate nell’art.2364 c.c., p. 369 – 2. Il ruolo dell’assemblea ordinaria dopo la riforma del diritto societario:
a) le autorizzazioni statutarie per il compimento di atti degli amministratori nelle societàprive del consiglio di sorveglianza, p. 375 – 2.1. (Segue): b) assemblea, consiglio disorveglianza e consiglio di gestione,
p. 379 – 3. Assemblea straordinaria e organo gestorio.Le competenze attribuite dalla legge all’assemblea straordinaria statutariamente delegabili
agli amministratori e le competenze attribuite dalla legge agli amministratori statutariamente
delegabili all’assemblea straordinaria, p. 384
393 SEZIONE IIIL PROCEDIMENTO
BARBARA PETRAZZINI
1. Il procedimento assembleare tra novità legislative, dubbi interpretativi e direttive comunitarie,
p. 393 – 2. Le disposizioni finalizzate a valorizzare il ruolo del socio e la sua partecipazioneall’assemblea: a) la convocazione e l’informazione preassembleare, p. 397 – 2.1. (Segue):
b) il diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno e di presentare proposte di delibera,
p. 402 – 2.2. (Segue): c) la partecipazione e il voto a distanza, p. 406 – 3. Le disposizioni finalizzatea valorizzare il ruolo del socio di minoranza-investitore istituzionale: a) l’intervento
in assemblea tra titolarità del diritto e legittimazione all’esercizio del voto, p. 409 –
3.1. (Segue): b) il voto per delega, p. 415
423 Capitolo XI
Invalidità delle deliberazioni dell’assemblea di società per azioni
SALVATORE SANZO
1. Brevi considerazioni di ordine generale, p. 423 – 2. Il problema circa la persistenza dellacategoria dell’inesistenza delle delibere assembleari, p. 427 – 3. Le deliberazioni annullabili:
l’impatto pratico della nuova disciplina, p. 431 – 3.1. I casi di annullabilità: la non conformitàalla legge ed allo statuto, la violazione della buona fede e la casistica normativa in tema
di annullabilità, p. 432 – 3.2. Legittimazione attiva, termini per l’impugnazione e rimedi risarcitori:cenni e rinvio, p. 437 – 3.3. Gli effetti dell’annullamento. La delibera sostitutiva, p.438
– 4. La nullità: rilievi di ordine generale sulle diverse fattispecie, p. 443 – 4.1. La nullitàsanabile, p. 446 – 4.2. Effetti della nullità. La delibera sostitutiva: cenni e rinvio, p. 451 –
4.3. La nullità insanabile e le invalidità di «delibere speciali»: cenni, p. 452 – 5. Il procedimentodi impugnazione: ambito di efficacia, termini di decadenza, legittimazione attiva e relative
vicende processuali, p. 454 – 5.1. Le norme di procedimento: cenni, p. 459 – 5.2. Lasospensione dell’efficacia della deliberazione impugnata, p. 460 – 5.3. Il rimedio risarcitorio
in relazione alle delibere annullabili ed a quelle nulle, p. 462
465 Capitolo XII
L’amministrazione
MARINA SPIOTTA
1. Premessa, p. 465 – 2. Novità normative, p. 467 – 3. Nomina, p. 469 – 3.1. Società amministratricedi altra società? Compatibilità con il ruolo di lavoratore dipendente e di direttore
generale, p. 469 – 3.2. Amministratori di fatto, p. 475 – 3.3. Metodi di votazione, p. 480 –
4. Cessazione, p. 482 – 4.1. Clausola simul stabunt simul cadent, p. 482 – 4.2. Revoca, p.486 – 4.3. Rinuncia, p. 496 – 5. Rappresentanza, p. 497 – 5.1. I limiti legali al potere di rappresentanzadegli amministratori sono sempre opponibili?,
p. 498 – 5.2. L’estraneità degli attiall’oggetto sociale, p. 500 – 5.3. Ratifica dell’atto ultra vires compiuto dall’amministratore,
p. 502 – 6. Invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, p. 503 – 7. Interessidegli amministratori, p. 507 – 8. Compenso, p. 513 – 8.1. Risvolti tributari (cenni), p. 517 –
9. Responsabilità: considerazioni introduttive, p. 518 – 10. (Segue): analisi delle singoleazioni: presupposti sostanziali e problemi processuali, p. 520
549 Capitolo XIII
L’obbligo di corretta amministrazione e gli assetti adeguati
MAURIZIO IRRERA
1. L’obbligo di corretta amministrazione, p. 549 – 2. Il contenuto dell’obbligo di correttaamministrazione, p. 553 – 3. Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili quale declinazionedell’obbligo di corretta amministrazione,
p. 556 – 4. Gli assetti e la responsabilitàdegli amministratori, p. 561 – 5. Il riparto di competenza in tema di assetti tra consiglio di
amministrazione e organi delegati, p. 564
573 Capitolo XIV
Il collegio sindacale: struttura e funzioni
MARCO AIELLO
1. La composizione dell’organo ed i requisiti di professionalità dei suoi componenti, p. 573 –
2. La presidenza del collegio, p. 575 – 3. Le cause di ineleggibilità e di decadenza, p. 578 –
4. Nomina, durata dell’incarico, cessazione dall’ufficio e sostituzione, p. 581 – 5. I doveridei sindaci, p. 584 – 6. I poteri del collegio sindacale, p. 588
593 Capitolo XV
Il collegio sindacale: la responsabilità dei sindaci
STEFANO AMBROSINI
1. L’assolvimento dei doveri sindacali secondo la professionalità e la diligenza richieste dallanatura dell’incarico, p. 593 – 2. Responsabilità esclusiva e responsabilità concorrente: ilnodo della solidarietà con l’obbligazione risarcitoria degli amministratori,
p. 597 – 3. (Segue):il problema della quantificazione del danno alla luce della più recente giurisprudenza,
p. 601 – 4. La disciplina delle azioni di responsabilità, p. 608
617 Capitolo XVI
I poteri di denuncia dei soci al collegio sindacale e al tribunale
FRANCESCO MAINETTI
1. L’art. 2408 c.c.: premessa, p. 617 – 2. I soggetti legittimati, la forma della denuncia e isuoi contenuti, p. 618 – 3. La disciplina di cui all’art. 2408 c.c., p. 619 – 4. L’art. 2409, denunziaal tribunale. Premessa,
p. 620 – 5. Ambiti di applicazione del controllo giudiziariosulla gestione: il problema delle s.r.l. e altre questioni, p. 622 – 6. Presupposti oggettivi,
p. 625 – 7. Legittimazione attiva, p. 626 – 8. Il procedimento, p. 628 – 9. Ulteriori profiliprocessuali, p. 631
635 Capitolo XVII
Il controllo contabile
MARINA SPIOTTA
1. Utilizzo nella prassi, p. 635 – 2. Novità di carattere normativo interno..., p. 638 – 3. (Segue):…e comunitario, p. 644 – 4. Esame della giurisprudenza, p. 646 – 5. Ricognizione della
dottrina, p. 658 – 6. Posizioni assunte dagli operatori, p. 665 – 7. Problemi aperti, p. 666 –
8. Conclusioni de iure condito e prospettive de iure condendo, p. 672
673 Capitolo XVIII
Il modello dualistico
MARIA CRISTINA BREIDA
1. L’introduzione del modello dualistico nell’ordinamento italiano: dal d.lgs. 6/2003 alle Disposizionidi vigilanza della Banca d’Italia, p. 673 – 2. I caratteri strutturali del modello, p.675
– 3. La composizione del consiglio di gestione. Requisiti di onorabilità, professionalità eindipendenza e cause di ineleggibilità, p. 677 – 4. (Segue): la composizione del consiglio digestione nelle società quotate e nelle società bancarie,
p. 679 – 5. Nomina e revoca dei componentidel consiglio di gestione, p. 680 – 6. Incompatibilità e durata dell’incarico, p. 681 –
7. La struttura dell’organo: la delega di funzioni, p. 683 – 8. Il presidente del consiglio di gestione,
p. 687 – 9. Le funzioni del consiglio di gestione, p. 687 – 10. L’art. 2392: la responsabilitàdei componenti del consiglio di gestione, p. 689 – 11. L’azione sociale di responsabilitànei confronti del consiglio di gestione,
p. 690 – 12. (Segue): il procedimento, p. 692 – 13. (Segue):rinuncia e transazione, p. 695 – 14. Le altre azioni di responsabilità, p. 697 – 15. Strutturae composizione del consiglio di sorveglianza,
p. 702 – 16. Requisiti soggettivi di assunzionedella carica, p. 703 – 17. Cause di ineleggibilità e decadenza, p. 705 – 18. (Segue): la disciplinaapplicabile alle società quotate,
p. 707 – 19. Nomina e revoca dei componenti delconsiglio di sorveglianza, p. 708 – 20. Il presidente del consiglio di sorveglianza, p. 711 –
21. Le funzioni del consiglio di sorveglianza: nomina e revoca dei componenti del consigliodi gestione, p. 712 – 22. (Segue): l’approvazione del bilancio, p. 715 – 23. (Segue): le funzionidi vigilanza,
p. 717 – 24. Le altre competenze nominate: l’esercizio dell’azione di responsabilitànei confronti dei componenti del consiglio di gestione e la proposizione della denuncia
di gravi irregolarità, p. 721 – 25. (Segue): l’informativa all’assemblea, p. 723 – 26. (Segue):i poteri di informazione, di ispezione e controllo nelle società quotate, p. 724 – 27. (Segue):deliberazioni in ordine alle operazioni strategiche,
p. 728 – 28. Le altre competenze nominatedel consiglio di sorveglianza, p. 730 – 29. Le competenze implicite del consiglio disorveglianza,
p. 731 – 30. La responsabilità dei componenti del consiglio di sorveglianza, p.733 – 31. L’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di sorveglianza,
p. 736 – 32. L’adozione del modello: prime esperienze e prospettive applicative, p. 737
741 Capitolo XIX
Il modello monistico
MARIA CRISTINA BREIDA
1. L’introduzione del modello monistico nell’ordinamento italiano: evoluzione normativa eprime esperienze applicative, p. 741 – 2. La conformazione del modello, p. 744 – 3. Le fun-
zioni di vigilanza del comitato per il controllo sulla gestione, p. 749 – 4. Le modalità di eserciziodel controllo, p. 752 – 5. Le altre competenze nominate del comitato, p. 754 – 6. Ilcomponente del comitato di controllo quale amministratore non esecutivo,
p. 756 – 7. I poteriinformativi del comitato per il controllo sulla gestione, p. 758 – 8. (Segue): i poteri diinformazione, ispezione e controllo nelle società quotate,
p. 760 – 9. La diligenza richiesta aicomponenti del comitato, p. 761 – 10. La disciplina delle responsabilità nel sistema monistico,
p. 763
PARTE III
LIBRI SOCIALI E BILANCIO
769 Capitolo XX
Introduzione alla disciplina del bilancio
ORESTE CAGNASSO
773 Capitolo XXI
Libri sociali e bilancio
LUCIANO QUATTROCCHIO
1. I prospetti di conto, p. 773 – 2. I criteri di valutazione, p. 774 – 2.1. Le operazioni in valuta,
p. 774 – 3. La nota integrativa, p. 774 – 3.1. Le riduzioni di valore applicate alle immobilizzazionimateriali e immateriali, p. 774 – 3.2. Le informazioni sulle operazioni con particorrelate e sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale,
p. 775 – 3.3. Gli strumenti finanziariderivati, p. 777 – 3.4. Le immobilizzazioni finanziarie, p. 781 – 4. La relazione sulla
gestione, p. 782 – 4.1. I principi generali, p. 782 – 4.2. I rischi interni ed esterni, p. 784 –
4.3. Gli indicatori finanziari, p. 785 – 4.4. Le informazioni relative all’ambiente e al personale,
p. 786 – 4.5. I rischi derivanti dagli strumenti finanziari, p. 787 – 5. L’azione di responsabilitànei confronti dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
p. 789 – 6. Il bilancio in forma abbreviata, p. 790 – 7. I principi contabili internazionali. Cenni,
p. 791
PARTE IV
SOCIETÀ PER AZIONI: MODIFICAZIONI STATUTARIE
795 Capitolo XXII
Introduzione alla disciplina delle modificazioni statutarie
STEFANO A. CERRATO
1. La disciplina vigente e i problemi aperti, p. 795 – 2. Il procedimento di verifica notarile edi iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, p. 796 – 3. Il diritto di recesso,
p. 797 – 4. Le operazioni di aumento del capitale, p. 800 – 5. Le operazioni di riduzione delcapitale, p. 805
807 Capitolo XXIII
Le modificazioni statutarie: esame della disciplina e delle novità normative ed esegetiche
807 SEZIONE IIL PROCEDIMENTO DI VERIFICA NOTARILE E DI ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
STEFANO A. CERRATO
1. Una questione non risolta: la natura ed il contenuto del controllo notarile, p. 807 – 2. Unaquestione nuova: l’efficacia delle modificazioni dello statuto, p. 810
815 SEZIONE IIIL DIRITTO DI RECESSO
STEFANO A. CERRATO
1. Le cause di recesso: questioni ermeneutiche, p. 815 – 2. La dichiarazione di recesso ed ilprocedimento di liquidazione, p. 821
827 SEZIONE IIILE OPERAZIONI DI AUMENTO DEL CAPITALE
STEFANO A. CERRATO
1. Il «conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima» (artt. 2343 ter, 2343quater, 2440 bis introdotti dal d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142): osservazioni a prima lettura,
p. 827 – 2. Profili problematici di disciplina della delega per l’esclusione o la limitazione deldiritto di opzione: quorum, procedura, «criteri a cui gli amministratori devono attenersi»,
p. 831 – 3. Aumento inscindibile, aumento scindibile ed aumento scindibile con efficacia«progressiva», p. 839 – 4. Diritto di opzione ed esclusione «semplificata »: profili problematici,
p. 840 – 5. Altri aspetti di disciplina delle operazioni di aumento del capitale meritevolidi segnalazione, p. 845 – 6. Il problema della competenza per l’emissione degli «strumenti
convertibili in azioni ordinarie» previsti dall’art. 12, l. 2/2009, p. 846
849 SEZIONE IVLE OPERAZIONI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE
STEFANO A. CERRATO
1. La riduzione di capitale volontaria: questioni esegetiche, p. 849 – 2. La delega all’organoamministrativo per la riduzione di capitale per perdite, p. 851 – 3. Altri aspetti di disciplina
delle operazioni di riduzione del capitale per perdite meritevoli di segnalazione, p. 856
PARTE V
SOCIETÀ IN MANO PUBBLICA
861 Capitolo XXIV
Introduzione alla disciplina della società in mano pubblica
IVAN DEMURO
1. La società (in mano) pubblica, p. 861 – 2. La compatibilità delle deroghe al diritto comunecon il diritto comunitario e la sua influenza sulla disciplina della golden share, p. 865 –
3. (Segue): l’incompatibilità con la nomina diretta ex art. 2449 c.c. che attribuisce un controllo«sproporzionato», p. 869
873 Capitolo XXV
Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
IVAN DEMURO
1. La nuova formulazione dell’art. 2449 c.c., p. 873 – 2. La nomina diretta nelle società chenon fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, p. 874 – 2.1. (Segue): il diritto di nominadiretta del socio pubblico di maggioranza,
p. 877 – 2.2. (Segue): il diritto di nomina direttadel socio pubblico di minoranza, p. 878 – 2.3. Il controllo sproporzionato nei diversi organisociali,
p. 880 – 3. Revoca, equiparazione con i soggetti nominati ordinariamente e (mancataprevisione della) disciplina transitoria, p. 881 – 4. La nomina diretta nel sistema dualistico,
p. 884 – 5. (Segue): nel sistema monistico, p. 887 – 6. La disciplina «finta» dettata perle società che fanno ricorso al capitale di rischio, p. 890
PARTE VI
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
899 Capitolo XXVI
Introduzione alla disciplina della società a responsabilità limitata
ORESTE CAGNASSO
1. Una sintesi del dato normativo: la fattispecie e la costituzione, p. 899 – 2. I conferimenti,
p. 900 – 3. I finanziamenti dei soci, p. 902 – 4. La partecipazione, p. 903 – 5. Il recesso,
p. 904 – 6. L’esclusione, p. 905 – 7. Gli organi ed i procedimenti decisionali, p. 906 – 8. Lemodificazioni dell’atto costitutivo, p. 910 – 9. I titoli di debito, p. 911 – 10. Un primo bilancio:i nuovi dati normativi,
p. 912 – 11. Il recepimento del tipo e delle relative opzioni nellaprassi, p. 914 – 12. La dottrina e la giurisprudenza, p. 916
921 Capitolo XXVII
La costituzione ed i conferimenti
ANGELO BERTOLOTTI
1. Atto costitutivo e statuto: una possibile coesistenza. La posizione della dottrina in caso dicontrasto tra clausole, p. 921 – 2. I conferimenti. Il capitale quale punto di riferimento centrale(rinvio),
p. 923 – 3. In particolare, il conferimento di prestazione d’opera o di servizi(art. 2464, 6° co.). Gli interrogativi della dottrina, p. 925 – 4. Considerazioni alla luce della
recente introduzione degli artt. 2343 ter e quater, anche con riferimento all’art. 2464, 6° co.,
p. 927 – 5. L’art. 2464, 4° e 6° co., a proposito del novellato art. 151 l. fall., p. 929 – 6. Gli«acquisti pericolosi». L’art. 2465, 2° co., di fronte all’«acquisto» di un’opera o di servizi,
p. 931 – 7. Richiami giurisprudenziali a proposito dei patti parasociali, p. 933
937 Capitolo XXVIII
I finanziamenti dei soci
ANGELO BERTOLOTTI
1. I finanziamenti: le ragioni di una disciplina, p. 937 – 2. La fattispecie disciplinata dall’art.2467 c.c. I problemi interpretativi e la dialettica dottrinale, p. 939 – 3. L’applicazione deiprincipi espressi dall’art. 2467 oltre l’ambito della società a responsabilità limitata. L’art.
2497 quinquies, p. 943
945 Capitolo XXIX
Le partecipazioni dei soci
ANGELO BERTOLOTTI
1. Considerazioni preliminari, p. 945 – 2. Le novità legislative a proposito del trasferimentodella partecipazione. Le integrazioni conseguenti alla l. 6 agosto 2008, n. 133. Le modifiche
introdotte agli artt. 2470 ss. per effetto della l. 28 gennaio 2009, n. 2, p. 946 – 3. Riflessionidella dottrina nel caso di pluralità di acquirenti della medesima partecipazione: la pubblicità
come mezzo di soluzione del conflitto, p. 949 – 4. La giurisprudenza di fronte al problemadella garanzia nel trasferimento della partecipazione, p. 952 – 5. Una recente sentenza di legittimitàa proposito delle clausole statutarie di gradimento,
p. 954 – 6. Ancora la giurisprudenza,questa volta a proposito delle clausole di prelazione, p. 954 – 7. I «particolari dirittidei soci». L’art. 2468, 3° co.: rilievi della dottrina,
p. 956 – 8. (Segue): il problema della trasferibilitàdei «particolari diritti», p. 957 – 9. (Segue): ancora la dottrina a proposito del contenuto
dei «particolari diritti», p. 961
965 Capitolo XXX
La disciplina del recesso e dell’esclusione
ANGELO BERTOLOTTI
1. Osservazioni di carattere generale a proposito del recesso, p. 965 – 2. Le fattispecie di recesso.Riflessioni della dottrina sugli ambiti di autonomia, p. 969 – 3. Il recesso nella società
contratta a tempo indeterminato. L’art. 2473, 2° co., e la sua interpretazione secondo la dottrina,
p. 971 – 4. L’esclusione del socio, p. 974 – 5. Alcune decisioni della giurisprudenza aproposito di clausole inserite nell’atto costitutivo concernenti il diritto di recesso del socio o
la sua esclusione, p. 977
981 Capitolo XXXI
L’amministrazione della società
ANGELO BERTOLOTTI
1. Una premessa in argomento. Con qualche richiamo giurisprudenziale sul compenso degliamministratori, p. 981 – 2. Osservazioni della dottrina sulla responsabilità degli amministratori,
p. 983 – 3. Posizioni della dottrina ed oscillazioni (molte) della giurisprudenza a propositodel controllo dei soci (art. 2476, 2° co.)…, p. 985 – 4. …della legittimazione attiva all’eserciziodell’azione sociale di responsabilità (art. 2476, 3° co.)…,
p. 988 – 5. …e del provvedimentocautelare di revoca degli amministratori (ancora l’art. 2476, 3° co.), p. 991 –
6. Decisioni altalenanti anche a proposito dell’azione dei creditori sociali. L’azione dei singolisoci e dei terzi, p. 995 – 7. La responsabilità dei soci. Il novellato art. 146, 2° co., lett.
b), l. fall., in relazione all’art. 2476, 7° co., p. 998
1001 Capitolo XXXII
Il collegio sindacale
ANGELO BERTOLOTTI
1. Qualche richiamo alla disciplina, alla dottrina ed alla giurisprudenza, p. 1001 – 2. Il problemadell’applicabilità della denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., p. 1003
1007 Capitolo XXXIII
Le decisioni dei soci
PAOLO RAINELLI
1. Le competenze dei soci: la dottrina e la prassi notarile sulla derogabilità dell’art. 2479, 1°co., c.c., p. 1007 – 2. Il procedimento non assembleare: il dibattito sui criteri di distinzionetra consultazione scritta e consenso espresso per iscritto,
p. 1009 – 3. La legittimazione all’avviodel procedimento: il contrasto giurisprudenziale sull’applicazione analogica dell’art.
2367 c.c., p. 1012 – 4. Il procedimento assembleare: gli altri chiarimenti forniti dal notariato,
p. 1013 – 5. L’invalidità delle decisioni: dibattito sul superamento della distinzione tra nullitàed annullabilità e rassegna giurisprudenziale in tema di inesistenza, p. 1017
1021 Capitolo XXXIV
Il bilancio
PAOLO RAINELLI
1. Il bilancio di esercizio nella società a responsabilità limitata: il rinvio alla disciplina dellesocietà per azioni, p. 1021 – 2. La formazione e l’approvazione del bilancio (modalità), p.1022
– 3. I tratti specifici del bilancio nel modello a responsabilità limitata: la rilevazione deifinanziamenti dei soci, dei titoli di debito e dei conferimenti d’opera e servizi, p. 1025 –
4. L’assenza di interventi giurisprudenziali, p. 1027
1029 Capitolo XXXV
Le modificazioni dell’atto costitutivo. I titoli di debito
ANGELO BERTOLOTTI
1. Considerazioni preliminari. I quorum deliberativi delle modificazioni ed il metodo adottabile,
p. 1029 – 2. L’aumento di capitale: generalità, p. 1032 – 3. (Segue): problemi connessial diritto di opzione, tra giurisprudenza e dottrina, p. 1034 – 4. La riduzione volontaria del
capitale. L’art. 2482, p. 1038 – 5. La riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo,
p. 1040 – 6. La riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo, p. 1042 – 7. I titoli di
debito, p. 1046 – 8. (Segue): alcuni profili problematici: l’eventuale rapporto con l’art. 2467,l’ipotesi di titoli di debito convertibili, il soggetto responsabile della solvenza della società,
p. 1048
PARTE VII
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ
1055 Capitolo XXXVI
I gruppi di società
MIA CALLEGARI
1. La configurazione del gruppo nella novella, p. 1055 – 1.1. Prime considerazioni, p. 1055 –
1.2. Gruppo di fatto o di diritto?, p. 1057 – 1.3. Imputabilità della direzione unitaria e strutturadel gruppo, p. 1059 – 2. Gestione dell’impresa e interesse delle società controllate,
p. 1066 – 3. Trasparenza ed informazione, p. 1070 – 4. L’«abuso» di direzione unitaria,
p. 1078 – 5. Il diritto di recesso del socio, p. 1095 – 6. L’autonomia privata nei gruppi. Il regolamentodel gruppo, p. 1100
PARTE VIII
OPERAZIONI STRAORDINARIE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1109 Capitolo XXXVII
Introduzione alla disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di
capitali e delle operazioni straordinarie
ORESTE CAGNASSO
1. Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali, p. 1109 – 2. Le operazionistraordinarie, p. 1112 – 3. Una sintesi del dato normativo: la trasformazione, p. 1114 – 4. La
trasformazione omogenea, p. 1116 – 5. La trasformazione eterogenea, p. 1117 – 6. La fusione,
p. 1118 – 7. La scissione, p. 1123
1127 Capitolo XXXVIII
Operazioni straordinarie. Trasformazione
ANGELO BERTOLOTTI
1. Ancora qualche considerazione in generale sulla trasformazione. Con cenni sui limiti ex
art. 2499 c.c. e sulla forma, p. 1127 – 2. La trasformazione omogenea, p. 1132 – 2.1. La trasformazioneomogenea progressiva. Note sulla perizia di stima (art. 2500 ter) e sul consenso
dei creditori sociali (art. 2500 quinquies), p. 1132 – 2.2. La trasformazione omogenea regressiva.Il consenso dei soci destinati ad assumere responsabilità illimitata nella società trasformata
(art. 2500 sexies); il diritto di recesso, p. 1134 – 3. La trasformazione eterogenea.Ammissibilità di ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore; in particolare,
l’impresa individuale, p. 1137 – 3.1. (Segue): considerazioni a proposito della comunione diazienda, p. 1139 – 3.2. Ancora a proposito di trasformazione eterogenea. Problemi di pubblicità,
p. 1142 – 4. Una peculiare fattispecie di trasformazione eterogenea, …ma, forse, nondel tutto, p. 1143 – 5. Invalidità della trasformazione. L’art. 2500 bis. Note di dottrina e giurisprudenza,
p. 1144
1147 Capitolo XXXIX
Operazioni straordinarie. Fusione
ANGELO BERTOLOTTI
1. Premessa, p. 1147 – 2. La fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. Il mergerleveraged buy-out. Osservazioni, talora fortemente critiche, della dottrina, p. 1148 – 3. Ancora
la dottrina a proposito delle operazioni cosiddette di leveraged cash-out e di leveraged
recapitalization o di recap, p. 1153 – 4. L’invalidità. La rilevanza solo risarcitoria dell’invaliditàad avvenuta pubblicità dell’atto di fusione: osservazioni della dottrina ed applicazioni
in giurisprudenza, p. 1157 – 5. (Segue): il preventivo procedimento di opposizione. Le modalità,
p. 1160 – 6. L’art. 2504 bis, 1° co. Il principio della prosecuzione dei rapporti pereffetto della fusione: i dubbi, p. 1163 – 7. La novità legislativa. Il d.lgs. 30 maggio 2008,
n. 108: le fusioni transfrontaliere, p. 1166
1173 Capitolo XL
Operazioni straordinarie. Scissione
ANGELO BERTOLOTTI
1. La scissione: vecchia e nuova disciplina, tra dottrina e giurisprudenza. La natura giuridicadell’istituto. La responsabilità per gli elementi extravaganti passivi, p. 1173 – 2. La scissione
inversa, p. 1177
1181 Capitolo XLI
Operazioni straordinarie e fallimento
ANGELO BERTOLOTTI
1. Il fallimento di società oggetto di precedente trasformazione, fusione o scissione: i socigià illimitatamente responsabili, alla luce del «nuovo» art. 147 l. fall., p. 1181
1183 Capitolo XLII
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
MARCELLA SARALE
1. Uno sguardo d’insieme, p. 1183 – 2. Questioni di diritto transitorio, p. 1184 – 3. Le causedi scioglimento, p. 1187 – 4. (Segue): problemi nuovi legati a cause di scioglimento già presenti
nel testo ante riforma, p. 1189 – 5. (Segue): le «nuove cause» di scioglimento, p. 1196 –
6. L’operatività delle cause di scioglimento, p. 1199 – 7. (Segue): causa di scioglimento edoveri degli amministratori, p. 1200 – 8. (Segue): causa di scioglimento e gestione della società,
p. 1204 – 9. Il procedimento di liquidazione. La nomina dei liquidatori, p. 1208 –
10. (Segue): i poteri dei liquidatori, p. 1210 – 11. (Segue): le specifiche attribuzioni dei liquidatori,
p. 1213 – 12. L’informazione contabile durante la liquidazione, p. 1218 – 13. Larevoca della liquidazione, p. 1220 – 14. La chiusura della liquidazione e l’estinzione della
società, p. 1224
PARTE IX
LE COOPERATIVE
1231 Capitolo XLIII
Introduzione alla disciplina della società cooperativa dopo la riforma
GUIDO BONFANTE
1. Una premessa. Le caratteristiche essenziali della cooperativa alla luce della riforma del2003, p. 1231 – 2. Il nuovo volto della cooperativa dopo quattro anni, p. 1233 – 3. Gli «assestamenti» post riforma in tema di mutualità e dintorni,
p. 1236 – 4. Gli altri «assestamenti»:la partecipazione sociale e i soci, p. 1240 – 5. La c.d. finanza cooperativa. Gli strumenti finanziari,
p. 1243 – 6. Costituzione e forme organizzative. La scelta fra s.p.a. e s.r.l., p. 1246 –
7. Il principio di compatibilità nel modello s.p.a. e s.r.l., p. 1249 – 8. Le modalità di costituzione.L’iscrizione al registro delle imprese e all’Albo delle cooperative. La nullità,
p. 1251 – 9. Gli organi sociali, p. 1254 – 10. Bilancio, capitale, riserve, p. 1257 – 11. I gruppicooperativi, p. 1260 – 12. Le operazioni straordinarie, p. 1261 – 13. I controlli, p. 1263 –
14. L’insolvenza, p. 1264 – 15. Una conclusione (piccola) e un rinvio, p. 1266
1269 Capitolo XLIV
Le società cooperative
MAURIZIO CAVANNA
1. La mutualità, prevalente e non, p. 1269 – 2. (Segue): i ristorni, p. 1274 – 3. (Segue): mutualitàcooperativa e aiuti di Stato, p. 1278 – 4. La fase costitutiva. Cenni ad alcuni aspettiproblematici,
p. 1280 – 5. (Segue): l’Albo delle società cooperative, p. 1283 – 6. La disciplinadella partecipazione. Possibili forme rappresentative, p. 1284 – 7. (Segue): la disciplinadella partecipazione: il recesso,
p. 1288 – 8. (Segue): la disciplina della partecipazione. I sociin prova, p. 1292 – 9. (Segue): cenni al trasferimento delle partecipazioni nelle cooperative
adottanti la forma della s.r.l., p. 1294 – 10. Gli strumenti finanziari e i soci finanziatori,
p. 1296 – 11. Gli organi assembleare e amministrativo. Il modello dualistico di governance,
p. 1302 – 12. L’organo di controllo. Il controllo giudiziario, p. 1309 – 13. Il gruppo cooperativoparitetico, p. 1314 – 14. Trasformazione, fusione e scissione, p. 1317 – 15. Insolvenza,
p. 1321 – 16. Le recenti novità della l. 23 luglio 2009, n. 99, p. 1324
1329 Capitolo XLV
Le mutue assicuratrici
EVA DESANA
1. Le mutue assicuratrici dopo la riforma, p. 1329
PARTE X
PROFILI PENALISTICI
1335 Capitolo XLVI
Considerazioni generali
ANDREA PERINI
1339 Capitolo XLVII
Profili di novità attinenti la tutela penale dell’informazione societaria
ANDREA PERINI
1. La riforma della tutela del risparmio e le modifiche apportate alle false comunicazioni sociali:rilievi generali, p. 1339 – 2. La rilevanza amministrativa delle falsità «sotto soglia»,
p. 1341 – 3. Natura e ambito operativo delle soglie di punibilità alla luce della giurisprudenza,
p. 1342 – 3.1. Gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, p. 1342 –
3.2. L’intervento della Cassazione, p. 1346 – 3.2.1. Una lettura «europeista» delle fattispecieincriminatrici?, p. 1350 – 3.2.2. Una pronuncia che mette a nudo le esigenze di riforma dellefattispecie di false comunicazioni sociali,
p. 1351 – 4. L’elemento soggettivo del «nuovo» illecitoamministrativo, p. 1352 – 5. Sanzione penale e sanzione amministrativa: la «fuga in
avanti» del legislatore. Cenni alla prescrizione dell’illecito penale e dell’illecito amministrativo,
p. 1355 – 6. Sulla natura giuridica dei co. 4° e 5° dell’art. 2622 c.c., p. 1358 –
7. Oltre i confini delle false comunicazioni sociali: la tormentata storia del falso in prospetto,
p. 1360 – 7.1. Il falso in prospetto nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, p. 1361 – 7.2. Cenni alla successione di norme tra art. 2623 c.c. ed art.
173 bis t.u.f., p. 1362 – 8. Ambito applicativo dell’art. 2624 c.c. dal 12 gennaio 2006,
p. 1364
1367 Capitolo XLVIII
Profili di novità attinenti la fattispecie di infedeltà patrimoniale
GIANLUCA RUGGIERO
1. Premessa, p. 1367 – 2. L’interesse oggetto di tutela, p. 1369 – 3. I soggetti attivi, p. 1370 –
4. L’interesse in conflitto, p. 1371 – 5. Il danno patrimoniale, p. 1373 – 6. La condotta punibile,
p. 1374 – 7. L’elemento soggettivo, p. 1376 – 8. L’infedeltà infragruppo, p. 1377
1383 Capitolo XLIX
Altri profili di novità in materia penale societaria
ANDREA PERINI
1. Le operazioni di leveraged buy-out all’indomani della riforma del diritto penale societario:l’intervento della Cassazione penale, p. 1383 – 1.1. Leveraged buy-out e reati societari,
p. 1384 – 1.1.1. Leveraged buy-out e restituzione dei conferimenti, p. 1384 – 1.1.2. Leveragedbuy-out e art. 2628 c.c., p. 1386 – 1.1.3. Leveraged buy-out e operazioni in pregiudiziodei creditori,
p. 1388 – 1.2. Leveraged buy-out e bancarotta, p. 1388 – 1.3. L’intervento dellaCassazione, p. 1391 – 1.4. Conclusioni: la sostenibilità economica del leveraged buy-out come
crinale tra la ristrutturazione societaria e la causazione dolosa del fallimento, p. 1391 –
2. La confisca per equivalente, p. 1393 – 2.1. La natura e l’irretroattività delle norme in materiadi confisca per equivalente, p. 1394 – 2.2. Il quantum sottoponibile a confisca per equivalente,
p. 1396 – 3. Orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità degli amministratoridi fatto e degli amministratori privi di deleghe operative, p. 1401 – 4. Altre pronunce
giurisprudenziali in materia penale societaria, p. 1403
1405 I PATRIMONI DESTINATI. Nota bibliografica di rinvio
1409 INDICE BIBLIOGRAFICO
1467 INDICE ANALITICO